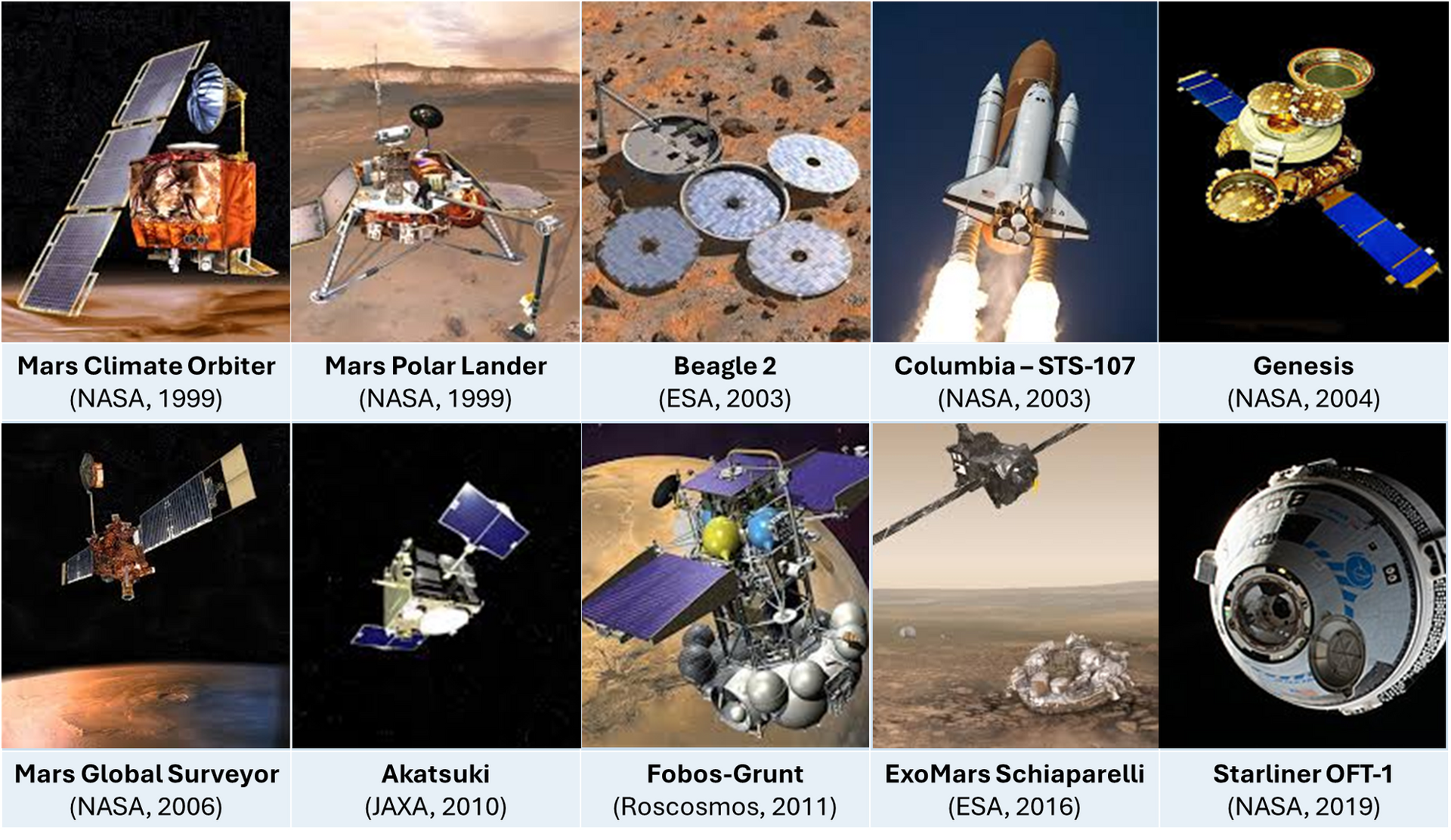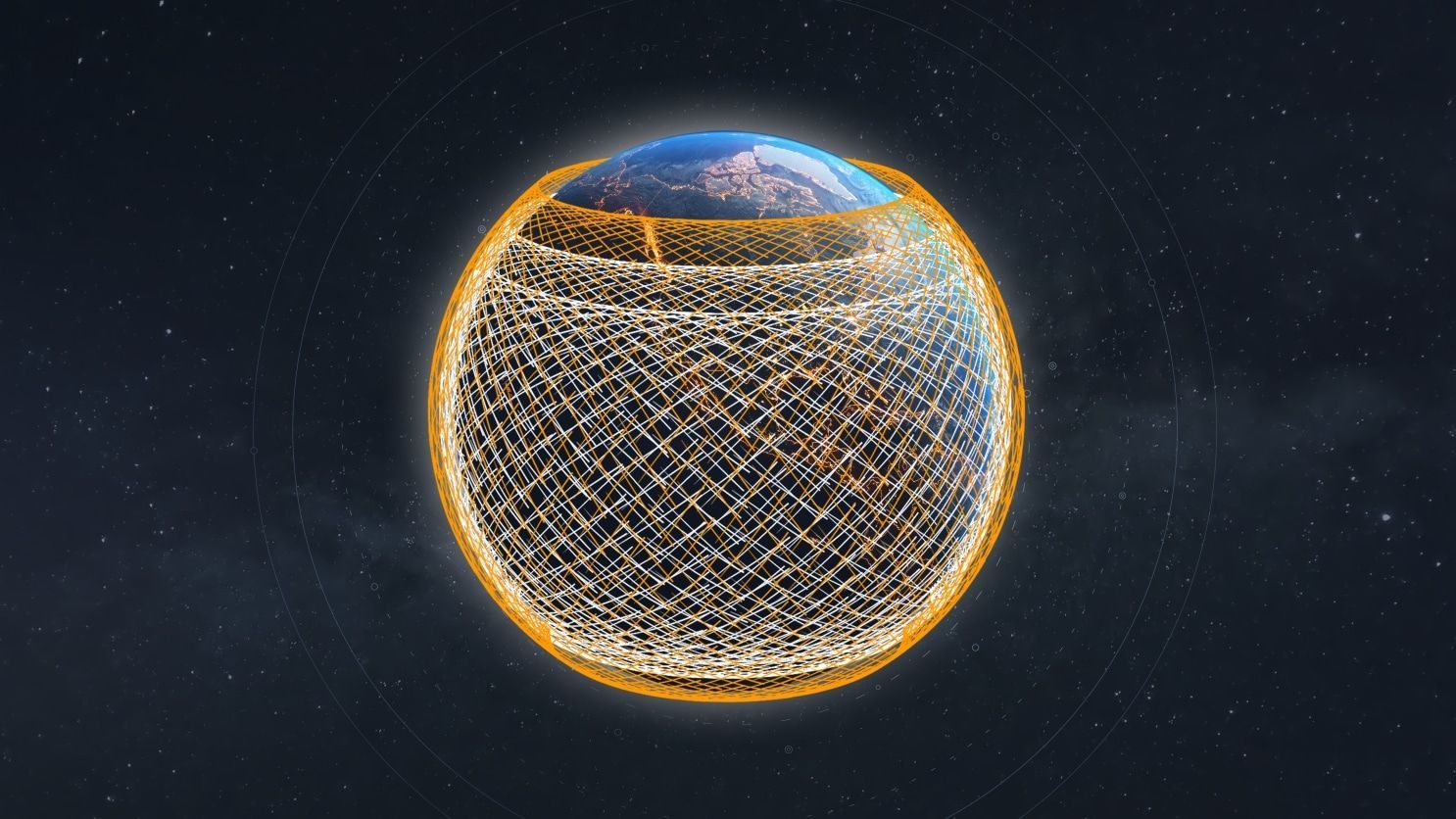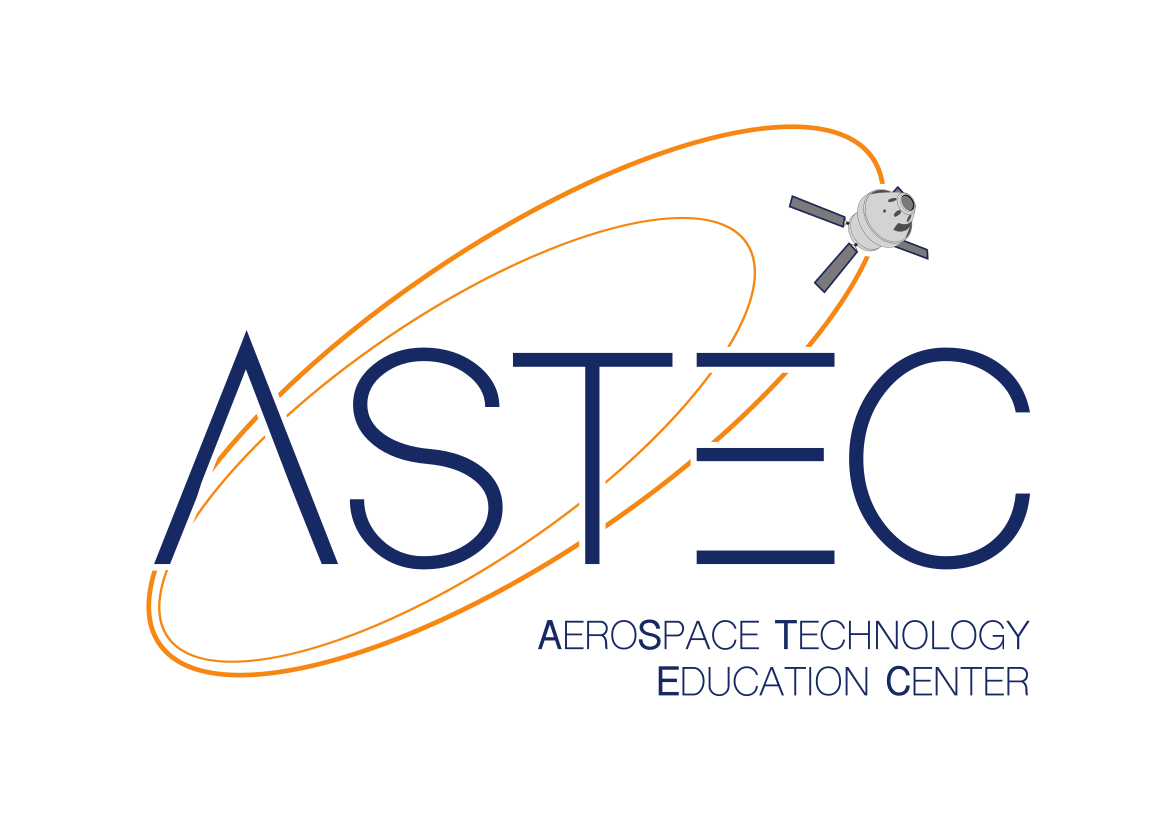La nascita dei vettori riutilizzabili
Storia dei Single-Stage-To-Orbit
Oggigiorno siamo più che abituati a guardare le immagini di parti di vettori spaziali sganciarsi a determinate altitudini, enormi cilindri che si staccano e ricadono sulla Terra. Questo fenomeno è comunemente noto come “stadiazione” ed è appunto una pratica ampiamente utilizzata dai velivoli spaziali.
Al momento del design, i serbatoi di propellenti che alimentano la propulsione vengono separati in compartimenti diversi, allo scopo di permetterne la separazione una volta esauriti. In questo modo è possibile liberarsi di “massa inerte” per agevolare e ridurre il costo delle manovre propulsive in seguito al superamento della fase di lancio della missione del vettore. Inoltre, la possibilità di adattare gli ugelli a diverse fasi di missione risulta in un vantaggio significativo.
Tuttavia, proprio questi stadi di separazione, tra i due ed i quattro, ponevano una grave limitazione sulla riutilizzabilità dei lanciatori, in un periodo ben precedente non solo al Falcon 9 di SpaceX, ma alla nascita di Elon Musk stesso.

Erano gli anni 60 del XX secolo quando l’ingegnere Philip Bono della Douglas Aircraft Company (compagnia che verrà in seguito accorpata alla McDonnel Aircraft, diventando la famosissima McDonnel Douglas, attualmente incorporata da Boeing) propose un veicolo che necessitasse di un unico stadio per raggiungere un’orbita, portando così ad uno dei primissimi concept di SSTO – Single-Stage-To-Orbit.
Il velivolo in questione era noto come OOST – One stage Orbital Space Truck, originariamente non riutilizzabile, aggiornato infatti da un modello che ovviasse a questa difficoltà, il ROOST.
Il concept rimase tale a causa delle limitazioni strutturali comportate da un tale design.
Negli anni successivi i suoi studi portarono al design del SASSTO nel 1967, una modifica del razzo Saturn che non prevedeva stadiazione. L’obiettivo era ridurre i costi del lancio sulla Luna. La tecnologia richiesta dal design era nuova e pertanto rischiosa, quindi il progetto non fu sviluppato.
Il titolo di primo concept di SSTO è conteso anche da Krafft Arnold Ehricke, noto per essere il co-designer del terzo stadio del razzo Centaur (combinatamente ad Atlas, portò il primo Surveyor sulla Luna nel 1966). Egli ideò, con il supporto della General Dynamics, il NEXUS, del quale non restano che diverse bozze di progetto, mai nemmeno costruito.

Benché questi progetti non videro la luce del sole, ad essi si devono gli studi propulsivi ed aerodinamici che avrebbero ispirato i recenti vettori riutilizzabili.
Il programma Space Shuttle decretò la chiusura degli studi sugli SSTO, per la preferenza di superfici alari sul velivolo.
Una delle pochissime idee effettivamente realizzate fu il McDonnel Douglas DC-X – Delta Clipper Experimental, il cui prototipo in scala fu non solo costruito, ma anche testato e migliorato fino al suo ultimo modello “Avanzato”, il DC-XA, che esplose in un test, quando uno delle quattro gambe di atterraggio non si dispiegò, causandone la caduta all’atterraggio. Tra i contributi principali di questi test si annoverano la dimostrazione di aborto missione in volo e di atterraggio verticale.

Anche se i velivoli SSTO non sono più di moda come un tempo, occasionalmente si effettuano teorie sul possibile utilizzo delle ultime tecnologie propulsive per provare a vincere la sfida più grande per questa peculiare categoria di razzi: la fase di lancio. Infatti, un motore nucleare potrebbe avere in teoria la capacità di portare un vettore in orbita, ma i rischi comportati da una soluzione simile sono troppo elevati, quindi, attualmente, resta solo una speculazione.

Condividi