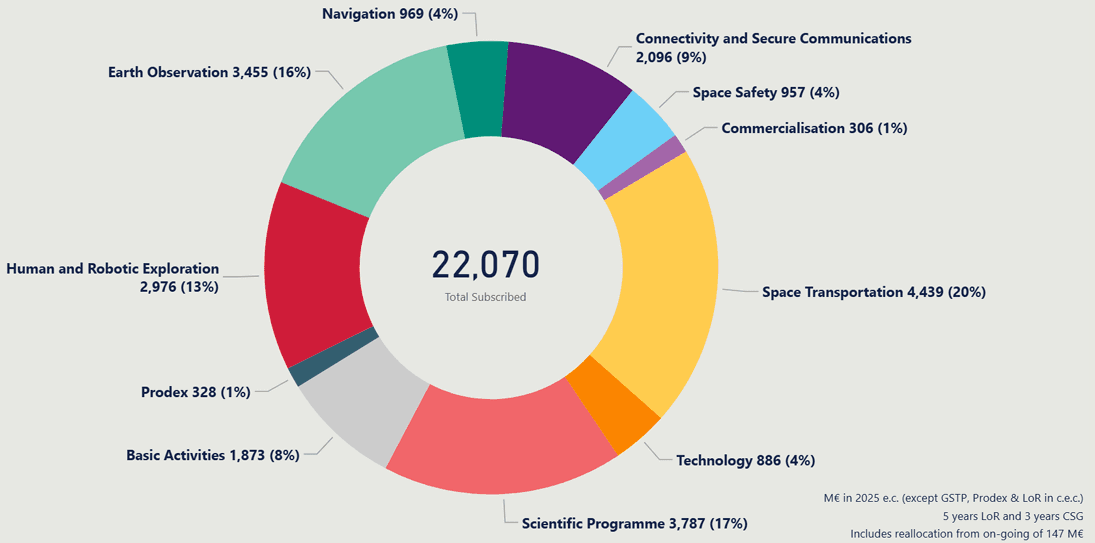Il mio primo telescopio
Come acquistare il primo telescopio?
La scelta del primo telescopio è certamente fonte di dubbi e perplessità, soprattutto per un novizio che si avvicina all’affascinante mondo dell’astronomia: già con una rapida ricerca nel web, si possono incontrare numerosissimi modelli che possono far sorgere non poche domande, una fra tutte:” quale differenza vi è tra uno e l’altro?”. In questo articolo andremo a conoscere le due categorie principali con alcuni consigli per iniziare.
Gli schemi ottici che vengono solitamente più usati per realizzare i telescopi amatoriali si distinguono principalmente in due tipi: i telescopi rifrattori e i telescopi riflettori.
Telescopi Rifrattori

I telescopi rifrattori sono costituiti da un lungo tubo chiuso sulla cui estremità frontale vengono installate due lenti che hanno la funzione di scomporre e ricomporre la luce che raccolgono.
Nell’uso amatoriale non raggiungono grandi aperture: difficilmente si trovano modelli che superino i 15 cm di diametro in quanto, oltre alle dimensioni che diventerebbero eccessivamente ingombranti, il costo per realizzare rifrattori a grande apertura non compenserebbe con i risultati ottenuti. Il loro utilizzo principale è il “planetario”, cioè l’osservazione della Luna, dei pianeti, e l’osservazione di stelle doppie: il telescopio rifrattore infatti, data la piccola apertura, risulta inadatto all’ osservazione di oggetti del profondo cielo come le galassie.
Esistono 2 sottotipi di questo telescopio: i rifrattori acromatici (figura1) e i rifrattori apocromatici. La differenza sostanziale tra questi due sistemi (oltre al prezzo) risiede nella capacità di mettere a fuoco nello stesso punto due colori contemporaneamente (nei rifrattori acromatici) oppure 3 (nei rifrattori apocromatici).
Per meglio comprendere il funzionamento e le differenze delle 2 ottiche occorre attingere qualche nozione dall’ottica: le lenti, in generale, scompongono la luce nei tre colori RGB, rosso, verde e blu. Questi 3 colori vengono successivamente ricomposti sul piano focale.
Il rifrattore di tipo ACROMATICO ricompone solo 2 di questi colori (lunghezze d’onda) con la conseguenza che gli oggetti osservati presenteranno un’aberrazione cromatica che consiste nel vedere un colore scuro ai bordi degli oggetti osservati;
nell’ottica APOCROMATICA invece, vengono ricomposti tutti e 3 i colori e dunque i colori scuri sono assenti, presentando un’immagine decisamente più incisa e contrastata. L’apocromatico, quindi, combina 2 diverse lenti, come nell’acromatico, ma dispone di uno o più elementi “correttivi” che riducono quasi a zero l’aberrazione cromatica.
Di conseguenza, a parità di diametro, un rifrattore apocromatico è decisamente molto più costoso, anche fino a 10 volte tanto, rispetto a un rifrattore acromatico tradizionale. Tuttavia, esistono in commercio degli accessori che permettono di correggere e di migliorare alcuni limiti che affliggono i rifrattori acromatici, anche se l’impiego di un apocromatico, anche se più costoso, è sempre consigliabile rispetto a una soluzione “corretta”.
I rifrattori apocromatici, proprio per le loro caratteristiche, sono i più gettonati e i più consigliati nel campo dell’astrofotografia: limitarsi solo a un uso “visuale” minimizzerebbe molto le potenzialità di questi strumenti.
Telescopi Rifrattori

Rispetto ai rifrattori, i telescopi riflettori sono più facili da costruire. Sono costituiti da uno specchio parabolico (o iperbolico, come nei telescopi Ritchey-Cretién), detto primario, che ha la funzione di raccogliere la luce e di convogliarla nel punto di fuoco della parabola e da uno specchio secondario. Vi sono diverse configurazioni, diversificate per usi, costi, pregi e difetti.
I riflettori newtoniani hanno un rapporto focale abbastanza corto, che generalmente si attesta su un valore di 5-6. Il loro principale utilizzo è certamente il planetario e il profondo cielo, in quanto riesce a risolvere oggetti anche poco luminosi proprio in virtù del suo rapporto focale. L’uscita visuale è posizionata vicino alla testa del tubo grazie a uno specchio di 90° che fa uscire lateralmente l’immagine nell’oculare. Vengono prodotti con diametri importanti, dai 15 cm in su, con alcuni modelli che arrivano ad avere un diametro di 30 o anche 50 cm.
Il difetto importante che affligge questo schema ottico è il COMA, un particolare difetto ottico che causa, ai bordi del campo visivo, una forma allungata delle stelle (che assomigliano a delle comete, da qui il nome coma) e che si può correggere applicando degli opportuni correttori. Questo difetto è tanto maggiore quanto più è corta la focale dello strumento. Di contro, un telescopio newton ha solitamente costi molto contenuti rispetto ai “colleghi” di pari diametro, con un ottimo rapporto qualità prezzo, cosa che lo rende molto appetibile anche come primo strumento.
Le immagini , cioè quelle attorno al centro del campo visivo sono pressoché perfette, a meno che non vi siano evidenti difetti ottici di fabbricazione.
Questo schema ottico è utilizzato, anche per la realizzazione dei cosiddetti telescopi “Dobson”, che non sono altro che riflettori newtoniani ma che vengono usati usando una montatura “a terra”, cioè semplicemente ancorando lo strumento a una base (solitamente in legno) appoggiata per terra, in modo da poter muovere lo strumento a proprio piacimento su entrambi gli assi ed avere una maneggevolezza notevole, pur se con uno strumento pesante e ingombrante. Particolarmente adatti e apprezzati per gli oggetti più lontani e, in particolare, per gli oggetti del profondo cielo, abbinati a oculari adatti a questo scopo vi offriranno visioni difficilmente replicabili con altri strumenti.

Fatta questa distinzione di base (vi sono altre categorie ma poco consigliate per chi inizia) per chi si vuole AVVICINARE a questa è disciplina senza spendere eccessivamente, il mio consiglio è quello di prendere o un piccolo rifrattore ACROMATICO (70-80-90mm di diametro) o un piccolo telescopio newton su configurazione newton o dobson (114/130/150mm). La cosa più importante da tenere conto è che, per rimanere accorti dal punto di vista economico, questi telescopi non possiedono motorizzazione (che aumenterebbe il prezzo) e quindi gli oggetti vanno cercati e inseguiti servendosi di atlanti o app per il cellulare. E’ però un modo sicuramente affascinante ed estremamente didattico per iniziare ad esplorare il cielo togliendosi non poche soddisfazioni.
Il consiglio successivo è quello di affidarsi ad esperti del settore, partecipando a serate organizzate dalle associazioni astrofile di zona, dove potrete toccare con mano questi telescopi e farvi consigliare adeguatamente. L’importante come dico sempre, è non farsi prendere dalla fretta e scegliere con saggezza.
Spero che questo piccolo articolo possa essere utile per chi si avvicina alla visione del cielo stellato, curioso di esplorare l’universo con occhi sempre nuovi!

Condividi